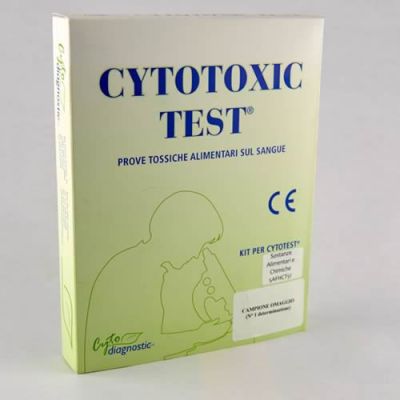Cytotest® - Cytotoxic Test®
Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro per intolleranze alimentari
Tabella dei contenuti
- Cytotest®- Cytotoxic test®
- Le intolleranze alimentari
- Differenza tra allergie e intolleranze
- Sintomi associati alle intolleranze alimentari
- Come si individuano le intolleranze alimentari
- Storia della tecnologia
- Descrizione del Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro Cytotest® - Cytotoxic Test®
- Materiale occorrente per l’esecuzione del test
- Preparazione del campione ematico
- Esecuzione del test
- Risultato del test
Cytotest®- Cytotoxic test®
Il Cytotest®- Cytotoxic test® è un Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro (IVD) utilizzato per l'identificazione e la valutazione di intolleranze alimentari (reazioni avverse agli alimenti non IgE mediate) mediante l’osservazione e la valutazione di eventuali alterazioni/modificazioni morfologiche dei leucociti presenti nel campione di sangue prelevato dal paziente e messo a contatto con gli estratti alimentari.
Il dispositivo Cytotest®- Cytotoxic test® è destinato all’uso esclusivamente professionale.
Le intolleranze alimentari
Le intolleranze alimentari, da non confondere con alle allergie alimentari IgE mediate, rappresentano un fenomeno concreto e molto diffuso e spesso sono responsabili di affezioni e condizioni di malessere che caratterizzano il nostro tempo.
Le intolleranze alimentari non comportano la produzione di anticorpi IgE ma si manifestano come reazioni cellulo-mediate ritardate verso alimenti assunti quotidianamente e/o frequentemente.
Differenza tra allergie e intolleranze
Il termine “allergia”, cioè altra reazione, venne usato per la prima volta nel 1906 da Clemens Von Pirquet, un medico viennese, specialista in pediatria.
Egli definì l’allergia come un’alterata capacità acquisita e specifica, di reagire a sostanze estranee alle cellule dell’organismo.
La reazione si esplica tramite l’azione del sistema immunitario, che rappresenta un vero e proprio sistema di difesa dell’organismo da tutti gli agenti esterni all’organismo stesso; tali agenti estranei possono essere: nocivi, quali microrganismi tipo virus, batteri ecc., o innocui, quali, per esempio, le sostanze chimiche e alimentari.
Molto semplicemente, il sistema immunitario è composto da diversi tipi di leucociti quali linfociti macrofagi, granulociti neutrofili, monociti, tutte chiamate fagociti, in quanto deputate all’inglobamento di sostanze tossiche e alla loro successiva eliminazione; i linfociti si dividono in due gruppi: linfociti T e linfociti B.
A loro volta i linfociti T si suddividono in: soppressori, ausiliari e killer.
I linfociti B sono molto importanti per la loro capacità di produrre le immunoglobuline, sostanze chimiche dirette contro il corpo estraneo, dette anticorpi specifici, che possono difendere l’organismo in diverse patologie infettive e allergiche.
La risposta immunitaria si articola sotto molteplici aspetti al livello delle varie componenti cellulari, sia con un contatto diretto intercellulare, sia con la produzione di immunoglobuline.
Quando si presenta un’infezione da microrganismi, il sistema immunitario, di solito, conserva la memoria del corpo estraneo che ha provocato l’infezione; si costituisce così il fenomeno dell’immunità.
Questo complesso fenomeno si realizza attraverso tappe ben precise nelle quali, in breve, alcuni linfociti contattano il corpo estraneo (detto antigene), passano informazioni ad altre cellule deputate a produrre specifiche sostanze, chiamate anticorpi, che aggrediranno a loro volta gli antigeni.
Gli anticorpi o immunoglobuline sono di cinque tipi principali: le IgA, le IgM, le IgD, le IgG (e sottotipi) e le IgE.
L’azione difensiva, oltre che con la produzione di immunoglobuline, si verifica mediante la liberazione di mediatori chimici, quali, tra i più importanti, l’istamina, la serotonina, gli enzimi lisosomiali, i fattori chemiotattici, il fattore di aggregazione piastrinica.
Vi sono quattro tipi distinti di reazioni difensive del sistema immunitario:
Tipo I
La reazione è mediata dalle IgE che vengono prodotte dopo l’esposizione agli allergeni.
Queste immunoglobuline si legano alla superficie dei mastociti, dei granulociti e dei linfociti basofili presenti a livello dei tessuti.
Quando l’allergene entrerà nell’organismo e vi sarà il contatto con le IgE, avverrà la liberazione istantanea, da parte delle cellule, dei mediatori chimici sopramenzionati, primo fra tutti l’istamina, spesso responsabile delle reazioni allergiche propriamente dette: eritema, edema, prurito, bruciore a livello cutaneo.
Tipo II
La reazione è mediata dalle IgM-IgG e dalle cellule, in questo caso i linfociti killer.
In questa reazione l’organismo combatte microrganismi viventi mediante la produzione di immunoglobuline IgM e IgG, che aderiscono alla parete cellulare dell’ospite in modo che i linfociti killer lo possano riconoscere.
Questo tipo di reazione si verifica, talvolta per errore, anche verso i costituenti stessi dell’organismo; in questo caso avremo le malattie autoimmunitarie; lo stesso fenomeno si può osservare con l’assunzione di farmaci tossici.
Tipo III
La reazione è mediata da immunocomplessi. In questa reazione si formano le immunoglobuline IgG e IgM contro antigeni “solubili” come, per esempio, le tossine batteriche, gli alimenti, le sostanze chimiche e naturali.
Le immunoglobuline prodotte si uniscono agli antigeni, attivando il complemento (serie di proteine presenti nel siero), e questo attrarrà i fagociti che distruggeranno i corpi estranei.
Tipo IV
La reazione è mediata dai linfociti T.
In questa reazione, che si sviluppa solitamente due o tre giorni dopo la comparsa della sostanza estranea, i linfociti T, citotossici, che sono stati sensibilizzati in precedenza, attaccano le cellule organiche infettate.
Questo tipo di reazione è quello che si presenta in caso di rigetto di organi trapiantati e di malattie degenerative; è detto anche immunoreazione ritardata.
Da quando si sono “scoperti” gli anticorpi IgE e si è visto chiaramente che molti sintomi allergici (rinite, naso chiuso, congiuntivite, occhi che lacrimano, asma, ecc.) sono correlati alla quantità di questi anticorpi nel sangue, si definiscono malattie allergiche solo quelle dove vi è una presenza elevata dei suddetti anticorpi.
Questo è stato di estrema importanza per definire i meccanismi alla base dei vari processi allergici ma contemporaneamente ha escluso dalla definizione di allergia tutti quei fenomeni di intolleranza alimentare che implicano un coinvolgimento del sistema immunitario ma senza la produzione di anticorpi IgE.
Quindi in conclusione si può parlare di allergie alimentari solo quando ritroviamo nel sangue un eccesso di immunoglobuline E (IgE) che in presenza della sostanza estranea (allergene) sia essa polline o polvere o alimento, si agganciano su alcuni tipi di globuli bianchi che liberano l’istamina che causerà infiammazione, gonfiore dei tessuti, ecc.
Si parla invece di intolleranze alimentari, quando non vi è la produzione di anticorpi IgE e le reazioni non sono immediate ma croniche.
I disturbi, infatti, non sono in diretta relazione all’assunzione ma si possono verificare a distanza di tempo fino a 72 ore dopo, i sintomi e le malattie si possono sviluppare a carico di qualsiasi organo-apparato-sistema.
Il meccanismo che causa lo scatenamento di queste manifestazioni si deve ricercare nella reazione del sistema immunitario che in presenza di alcuni alimenti li riconosce come dannosi ed estranei, e di conseguenza reagisce.
Nello specifico si parla di intolleranze alimentari quando:
- non vi è la produzione di anticorpi IgE;
- le reazioni non sono immediate ma croniche; i disturbi, infatti, non sono in diretta relazione all’assunzione dell’alimento ma si possono verificare a distanza di tempo fino a 72 ore dopo e sono una reazione cronica ad alimenti assunti frequentemente come grano, latte, pomodoro, olivo, caffè e così via;
- spesso, trattandosi di un accumulo di alimenti intollerati, sono proprio gli alimenti più graditi e che si mangiano quotidianamente a esserne i responsabili e la temporanea sensazione di benessere dopo l’assunzione degli stessi, si avverte perché si innesca un meccanismo simile a quello di dipendenza da alcol, droga o tabacco;
- il fenomeno, pertanto, si può accompagnare a disturbi di assuefazione, dipendenza e relativa astinenza in caso di sospensione;
- i sintomi e le malattie si possono sviluppare a carico di qualsiasi organo-apparato-sistema; il bersaglio può cambiare nel tempo e i disturbi causati dalle intolleranze alimentari possono essere anche molto diversi tra loro;
- i sintomi non sono proporzionali alla quantità dell’alimento intollerato introdotto, quindi non sono dose-dipendente, anche piccole quantità possono mantenere l’intolleranza;
- sono frequenti reazioni trasversali tra alimenti della stessa famiglia biologica o gruppo; quindi, assumere alimenti collaterali vuol dire non disintossicare l’organismo e mantenere l’intolleranza;
- dopo un periodo di astensione da cibi o additivi risultati tossici, l’intolleranza scompare e gli alimenti possono essere gradualmente reintrodotti.
Sintomi associati alle intolleranze alimentari
A volte, pur non essendo in presenza di una specifica malattia o di una patologia, si manifestano disturbi ricorrenti e persistenti che non trovano soluzione, qualunque sia l’approccio terapeutico.
Le manifestazioni legate alle intolleranze alimentari sono talvolta correlate a forti condizioni di stress, che rendono l’organismo più sensibile e che possono portare a disturbi emotivi tali da indebolire ancor più l’equilibrio psico-fisico.
I sintomi associati alle intolleranze alimentari, che si possono manifestare anche congiuntamente, in modo più o meno importante, sono:
astenia, cefalea, nausea, meteorismo, diarrea, gonfiori, dolori addominali post-prandiali, infezioni ricorrenti, dolori articolari, alterazioni cutanee come orticaria, disidrosi, eczemi, dermatiti, ritenzione di liquidi, disordini del peso corporeo con variazioni sia in eccesso che in difetto ma anche stanchezza cronica e insonnia e molte altre che riconoscono spesso nell’intolleranza alimentare la causa diretta-indiretta.
Come si individuano le intolleranze alimentari
Il Gold Standard nella diagnosi dell’intolleranza alimentare è la dieta ad eliminazione che consiste nell’eliminare per una o due settimane l’alimento (tutta la famiglia biologica) che viene assunto dal paziente con più frequenza, o che in base all’anamnesi si sospetta sia quello mal tollerato.
Il Cytotest® - Cytotoxic Test® è un metodo alternativo alla dieta ad eliminazione sicuramente più rapido ed efficace che si basa sull’osservazione e sulla valutazione di eventuali alterazioni/modificazioni morfologiche dei leucociti presenti nel campione di sangue prelevato dal paziente e messo a contatto con gli estratti alimentari.
Tra le metodiche diagnostiche, da sempre molto osteggiate e criticate, il Cytotest® o Cytotoxic Test® ha costantemente ottenuto riconoscimenti per l’affidabilità e l’efficacia.
Storia della tecnologia
La consapevolezza che gli alimenti potessero essere causa di disturbi anche gravi, si riscontra già nell'antichità con il medico greco Ippocrate.
Nel corso dei secoli molti altri studiosi hanno potuto verificare il fenomeno ma, solo nel 1924, i medici statunitensi, il Dott. H. Rinkel e, successivamente il Dott. T. G. Randolph enunciarono le loro teorie in merito alle reazioni “anomale” che l’assunzione di determinati alimenti poteva provocare nell’individuo.
Il primo a notare questa correlazione, fu Albert Rowe di Chicago nel 1920.
Rowe si accorse come numerosi pazienti miglioravano le loro diverse sintomatologie tipo coliti, dolori osteo-articolari, astenie, bronchiti asmatiche, riniti, ipertensioni, dismenorree, sintomi psichiatrici, cefalee, dermatiti ed altro alla sola sospensione di determinati alimenti; in taluni casi, addirittura, si aveva la completa remissione della sintomatologia precedentemente lamentata e resistente alle comuni terapie del tempo.
L’argomento venne affrontato per la prima volta nel 1951 dal Dott. T. G. Randolph di Chigago che, basandosi sugli studi di Rowe e di Rinkel, nella pubblicazione “Food Allergy”, ipotizzò come molte malattie croniche potessero avere origine da disordini alimentari.
Randolph definì questi fatti come “Allergia Alimentare” e questo termine non poté non dimostrarsi errato proprio quando l’Allergologia stava iniziando a definire ed a comprendere i meccanismi alla base delle “Allergie” ed a considerare come tali solo quelle manifestazioni legate ad un interessamento degli anticorpi IgE ed Istamina. Certamente Randolph aveva sbagliato nella definizione ma non nella sostanza clinica.
Quindi era chiaro ed evidente come tutti i fenomeni da cibo, descritti e curati da Randolph, non potevano rientrare nel campo dell’Allergologia e questo causò l’allontanamento, lo scetticismo e l’emarginazione scientifica del medico statunitense e dei suoi allievi, anche se, facendo digiunare, sotto rigoroso controllo, soggetti ospedalizzati e poi rialimentandoli con determinati cibi, giunse a scoprire un nuovo metodo terapeutico.
Tale metodo era tuttavia lungo e laborioso e per analizzare una cinquantina di alimenti erano necessarie molte settimane.
Si cercò quindi di trovare metodiche più veloci e nello stesso tempo abbastanza attendibili per raggiungere gli stessi risultati di Randolph e quindi di capire se nel sangue si potessero trovare indicatori che dimostrassero una causa alimentare dei disturbi presentati dai pazienti.
I primi approcci risalgono al 1947 quando alcuni immunologi anglosassoni, tra i quali Squier e Lee, osservarono in vitro una diminuzione del numero dei leucociti (fino ad un massimo del 33%) in pazienti che erano stati a contatto con determinati alimenti, ma, il primo studio sulla reazione citotossica degli alimenti sul sangue, fu condotto da Arthur Black che, nel 1956, ideò il Test Citotossico.
Arthur Black osservò il comportamento dei leucociti in vitro messi a contatto con gli allergeni alimentari rilevando modificazioni morfologiche cellulari in corrispondenza degli alimenti cui gli individui risultavano sensibili.
In presenza di anticorpi specifici verso l'allergene, i leucociti polimorfonucleati presentavano reazioni tossiche con morte cellulare che sopraggiungeva nell'arco di un periodo compreso tra i 15 minuti e qualche ora.
Se le reazioni erano forti e immediate, si sospettava la sensibilità clinica dell'allergene.
Il principio di Black è alla base di numerosi altri test di ricerca che si sono succeduti negli anni soprattutto in Usa e nei paesi anglosassoni.
Nel 1959 uno tra i più noti immunologi, il Prof. Byron Waksman, pubblicò diversi studi sugli effetti tossici delle reazioni antigene-anticorpi sulle cellule ed in particolare il testo "Aspetti cellulari e umorali in condizioni di ipersensibilità".
Ulteriori progressi nello studio e nella determinazione di un metodo di indagine furono conseguiti da vari studiosi, in particolare da Bryan e Bryan, agli inizi degli anni'60.
Il Test statunitense consisteva nel verificare in vitro l’azione citotossica di certi alimenti, azione che si manifestava con le modificazioni morfologiche dei neutrofili contenuti in un prelievo sanguigno e permetteva di diagnosticare le intolleranze alimentari evitando ai pazienti lunghe ed estenuanti diete a eliminazione.
Nel 1984 i fondatori di Cytodiagnostic srl importarono la metodica dagli Stati Uniti e cominciarono ad applicarla in Italia con l’obiettivo primario di standardizzarla, e di renderla riproducibile ed attendibile.
Per oltre 15 anni un team di ingegneri e professionisti del settore studia, progetta e perfeziona il Kit diagnostico sino ad elaborare un prototipo robotizzato per automatizzare e standardizzare la produzione dell’IVD che dal 2001 è fabbricato e commercializzato in Italia e all’estero da Cytodiagnostic srl.
Descrizione del Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro Cytotest® - Cytotoxic Test®
La confezione commerciale contiene un Kit con 5 determinazioni, ognuna per l’esecuzione di un test diagnostico, le Istruzioni per l’Uso (IFU) e la Dichiarazione di Conformità.
Le determinazioni sono composte da un numero di vetrini da laboratorio variabile a seconda della tipologia del kit utilizzato.
Il dispositivo viene fornito in cinque differenti tipologie:
Cytotest® - Cytotoxic Test®- 5FHCT51 Kit 51 alimenti
|
N. VETRINO |
SOSTANZA 1 |
SOSTANZA 2 |
SOSTANZA 3 |
|
VETRINO N. 00 |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
|
VETRINO N. 01 |
Grano |
Grano controllo |
Lievito |
|
VETRINO N. 02 |
Riso |
Mais |
Soia |
|
VETRINO N. 03 |
Latte |
Latte controllo |
Bovino |
|
VETRINO N. 04 |
Uova |
Uova controllo |
Pollo |
|
VETRINO N. 05 |
Maiale |
Coniglio |
Zucchero |
|
VETRINO N. 06 |
Pomodoro |
Patata |
Carciofo |
|
VETRINO N. 07 |
Fagiolo |
Pisello |
Oliva |
|
VETRINO N. 08 |
Tonno |
Gambero |
Carota |
|
VETRINO N. 09 |
Caffè |
The |
Cacao |
|
VETRINO N. 10 |
Mela |
Banana |
Arancia |
|
VETRINO N. 11 |
Limone |
Ananas |
Uva |
|
VETRINO N. 12 |
Fragola |
Ciliegia |
Pesca |
|
VETRINO N. 13 |
Mandorla |
Noce |
Camomilla |
|
VETRINO N. 14 |
Orzo |
Grano saraceno |
Lenticchia |
|
VETRINO N. 15 |
Aglio |
Trota |
Salmone |
|
VETRINO N. 16 |
Merluzzo |
Tacchino |
Cipolla |
|
VETRINO N. 17 |
Peperone |
Cavolfiore |
Cicoria |
Cytotest® - Cytotoxic Test® - 5AHCT21 Kit 21 sostanze chimiche
|
N. VETRINO |
SOSTANZA 1 |
SOSTANZA 2 |
SOSTANZA 3 |
|
VETRINO N. 00 |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
|
VETRINO N. 01 |
Glutine di grano |
Acido acetil-salicilico |
Acido L-ascorbico E30 |
|
VETRINO N. 02 |
Potassio sorbato E202 |
Sodio benzoato E211 |
Paraossibenzoato di metile E218 |
|
VETRINO N. 03 |
Etilvanillina |
Ammonio carbonato E503 |
Cremortartaro |
|
VETRINO N. 04 |
Lecitina di soia E322 |
Pirofosfato di sodio E450 |
Alginato di sodio E401 |
|
VETRINO N. 05 |
Solfato di nichel |
Tartrazina E102 |
Eritrosina E127 |
|
VETRINO N. 06 |
Farina di semi di carrube E410 |
Farina di semi di guar E412 |
Pectina E440 |
|
VETRINO N. 07 |
Lattosio |
Sodio metabisolfito E223 |
Acido citrico E330 |
Cytotest® - Cytotoxic Test® - 5AFHCT51 Kit 51 sostanze alimentari e chimiche
|
N. VETRINO |
SOSTANZA 1 |
SOSTANZA 2 |
SOSTANZA 3 |
|
VETRINO N. 00 |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
|
VETRINO N. 01 |
Grano |
Grano controllo |
Lievito |
|
VETRINO N. 02 |
Riso |
Mais |
Soia |
|
VETRINO N. 03 |
Latte |
Latte controllo |
Bovino |
|
VETRINO N. 04 |
Uova |
Uova controllo |
Pollo |
|
VETRINO N. 05 |
Maiale |
Coniglio |
Zucchero |
|
VETRINO N. 06 |
Pomodoro |
Patata |
Carciofo |
|
VETRINO N. 07 |
Fagiolo |
Pisello |
Oliva |
|
VETRINO N. 08 |
Tonno |
Gambero |
Carota |
|
VETRINO N. 09 |
Caffè |
The |
Cacao |
|
VETRINO N. 10 |
Mela |
Banana |
Arancia |
|
VETRINO N. 11 |
Glutine di grano |
Acido acetil-salicilico |
Acido L-ascorbico E30 |
|
VETRINO N. 12 |
Potassio sorbato E202 |
Sodio benzoato E211 |
Paraossibenzoato di metile E218 |
|
VETRINO N. 13 |
Etilvanillina |
Ammonio carbonato E503 |
Cremortartaro |
|
VETRINO N. 14 |
Lecitina di soia E322 |
Pirofosfato di sodio E450 |
Alginato di sodio E401 |
|
VETRINO N. 15 |
Solfato di nichel |
Tartrazina E102 |
Eritrosina E127 |
|
VETRINO N. 16 |
Farina di semi di carrube E410 |
Farina di semi di guar E412 |
Pectina E440 |
|
VETRINO N. 17 |
Lattosio |
Sodio metabisolfito E223 |
Acido citrico E330 |
Cytotest® - Cytotoxic Test® - 5FHCTR51 Kit 51 alimenti R
|
N. VETRINO |
SOSTANZA 1 |
SOSTANZA 2 |
SOSTANZA 3 |
|
VETRINO N. 00 |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
Controllo negativo |
|
VETRINO N. 01 |
Grano |
Grano controllo |
Lievito |
|
VETRINO N. 02 |
Riso |
Mais |
Soia |
|
VETRINO N. 03 |
Latte |
Latte controllo |
Bovino |
|
VETRINO N. 04 |
Uova |
Uova controllo |
Pollo |
|
VETRINO N. 05 |
Maiale |
Coniglio |
Zucchero |
|
VETRINO N. 06 |
Pomodoro |
Patata |
Girasole |
|
VETRINO N. 07 |
Fagiolo |
Pisello |
Oliva |
|
VETRINO N. 08 |
Tonno |
Gambero |
Carota |
|
VETRINO N. 09 |
Caffè |
The |
Cacao |
|
VETRINO N. 10 |
Mela |
Banana |
Arancia |
|
VETRINO N. 11 |
Limone |
Ananas |
Uva |
|
VETRINO N. 12 |
Fragola |
Mirtillo |
Pesca |
|
VETRINO N. 13 |
Mandorla |
Noce |
Camomilla |
|
VETRINO N. 14 |
Orzo |
Grano saraceno |
Avocado |
|
VETRINO N. 15 |
Aglio |
Trota |
Salmone |
|
VETRINO N. 16 |
Merluzzo |
Tacchino |
Cipolla |
|
VETRINO N. 17 |
Cetriolo |
Cavolfiore |
Zucca |
Cytotest® - Cytotoxic Test® - 5DCCT29 Kit ad uso veterinario per cane/gatto
|
N. VETRINO |
SOSTANZA 1 |
SOSTANZA 2 |
SOSTANZA 3 |
|
VETRINO N. 01 |
Controllo negativo |
Grano |
Lievito |
|
VETRINO N. 02 |
Riso |
Mais |
Soia |
|
VETRINO N. 03 |
Latte |
Bovino |
Agnello |
|
VETRINO N. 04 |
Uova |
Pollo |
Tacchino |
|
VETRINO N. 05 |
Maiale |
Coniglio |
Equino |
|
VETRINO N. 06 |
Pomodoro |
Patata |
Oliva |
|
VETRINO N. 07 |
Tonno |
Merluzzo |
Salmone |
|
VETRINO N. 08 |
Trota |
Barbabietola |
Orzo |
|
VETRINO N. 09 |
Avena |
Segale |
Grano saraceno |
|
VETRINO N. 10 |
Potassio Sorbato E202 |
Acido L-ascorbico |
Eritrosina E127 |
Materiale occorrente per l’esecuzione del test
L’esecuzione del test richiede strumenti e materiali comunemente utilizzati nei laboratori di analisi.
Per il prelievo del campione ematico:
- Disinfettanti per la cute: alcol, clorexidina o tamponi o salviette di iodopovidone
- Guanti non sterili
- Laccio emostatico, monouso
- Sistema di aghi (ago e siringa, o ago e provetta sottovuoto)
- Provette per la raccolta del sangue (Provetta con 0,5 ml di citrato di sodio al 3,8% o provetta per la coagulazione sodio citrato)
- Materiali per la medicazione (cotone idrofilo, cerotti, nastro adesivo)
Per l’esecuzione del test:
- Centrifuga da 1000-1500 giri/min con braccio oscillante o rotante
- Guanti non sterili
- Vassoio portavetrini da laboratorio 20 posti
- Micropipette da 200 ml, da 50 ml e da 2 ml
- Acqua distillata
- Cuvette EPPENDORF
- Vetrini coprioggetto 18 x 18
- Microscopio ottico con obiettivo 40x
Preparazione del campione ematico
Effettuare un prelievo endovenoso di sangue compreso tra i 2 e i 5 ml;
Il sangue prelevato deve essere miscelato all’interno di una provetta con 0.5 ml di Citrato di sodio al 3.8% o della comune provetta della coagulazione sodio citrato.
La miscela ottenuta deve essere centrifugata per 10 minuti a bassa velocità (1000-1500 giri/min) o lasciata sierare, possibilmente in frigo, e comunque ad una temperatura compresa tra 4°e 8° C.
Esecuzione del test
Le operazioni necessarie per l’utilizzo del dispositivo Cytotest® - Cytotoxic Test® e gli accorgimenti necessari per la buona riuscita dell’analisi, cui l’operatore deve rigorosamente attenersi, sono dettagliatamente descritti nelle Istruzioni per l’uso (IFU) presenti in ogni confezione commerciale e nel manuale d’uso fornito da Cytodiagnostic srl.
La lettura deve iniziare con l’osservazione del vetrino n. 00, il controllo negativo, che rappresenta l’elemento comparativo (bianco) ai fini della individuazione di una reazione positiva.
Si parla di reazione positiva solo qualora l’osservazione evidenzi un danneggiamento cellulare con una frequenza superiore al 60-70% sia all’interno dello stesso campo sia nella somma tra i campi analizzati.
La reazione deve essere classificata in base al tipo di alterazione morfologica del leucocita.
1° Grado - LEUCOCITI NORMALI:
- impilamento normale dei globuli rossi;
- globuli rossi normocromici;
- non si osserva nessuna deformazione morfologica dei globuli rossi;
- la membrana dei leucociti è ben conservata.

2° Grado - LEUCOCITI RIGONFI:
- impilamento normale dei globuli rossi;
- globuli rossi normocromici;
- leucociti vacuolizzati con leggera alterazione della membrana.
 3° Grado - LEUCOCITI VACUOLIZZATI:
3° Grado - LEUCOCITI VACUOLIZZATI:
- assenza di impilamento dei globuli rossi;
- globuli rossi tendenti all’ipocromia;
- leucociti vacuolizzati con una parziale rottura della membrana seguita da una perdita dei granuli citoplasmatici.

4° Grado - LEUCOCITI IN DISGREGAZIONE:
- l’impilamento dei globuli rossi è sempre meno evidente;
- i globuli rossi appaiono ipocromici;
- i leucociti si presentano in disgregazione con una rottura totale della membrana.

Risultato del test
Il risultato del test deve prevedere l’eliminazione dell’alimento per un periodo dipendente dal grado di reazione e precisamente:
2° Grado = 4 mesi di astinenza
3° Grado = 6 mesi di astinenza
4° Grado = 6 mesi di astinenza
Inoltre, per ogni alimento risultato positivo occorre eliminare per due mesi gli alimenti collaterali appartenenti alla stessa famiglia biologica
Sarà cura del nutrizionista vagliare attentamente i risultati in modo da prescrivere uno schema alimentare appropriato eliminando tassativamente gli alimenti risultati positivi e le relative famiglie biologiche.
 Italiano
Italiano  English
English